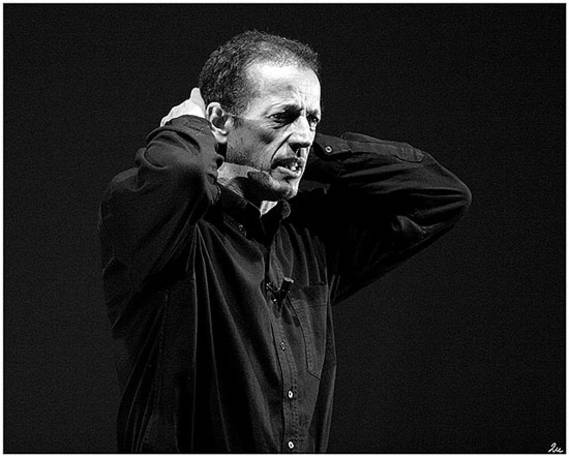


Quando ti è nata l’idea di questo spettacolo. Ha avuto difficoltà nel realizzarlo?
E’ nato per una diretta televisiva su Rai 2 il 9 maggio 1998, in occasione dei venti anni dalla morte di Aldo Moro. In un primo momento le difficoltà riguardavano la forma da dare allo spettacolo. Si rischiava l’ennesimo teatro di denuncia, con un taglio più giornalistico che artistico.
Dopo due mesi di lavoro, raccolta di materiale e srittura, non eravamo arrivati a capo di niente.
Poi un giorno Maria mi fece la domanda chiave “ Ma tu dov’eri il giorno in cui Moro fu rapito?”
Questa domanda ne generò altre a valanga, cosa avevo provato, cosa stavo facendo un attimo prima, cosa è successo la sera stessa e i giorni seguenti. Avevamo trovato la strada giusta e in pochi giorni il racconto si delineò come una personale esposizione di quei 55 giorni di prigionia di Moro, un racconto personale che diveniva anche spaccato generazionale
Ha fatto 400 esibizioni in Italia. Cosa ha significato per lei questa rappresentazione a New York. Che emozione ha provato? Ed il pubblico secondo lei guardava con gli stessi occhi di chi è in Italia?
Portare a New York questo spettacolo ha voluto dire far toccare a spettatori lontani nel tempo e nello spazio dalle vicende narrate , quel clima, l’atmosfera e le tensioni degli anni 70, un pezzo di storia del nostro paese, ma anche far sentire la sincerità di un racconto personale, che proprio per la sua carica autobiografica può suscitare emozioni e partecipazione anche in giovani americani che allora, ai tempi in cui si svolge il racconto, magari non erano neppure nati. Certamente lo sguardo era diverso da uno sguardo italiano, anche se spesso i giovani di oggi in Italia non è che siani molto più informati sui fatti del nostro passato prossimo.
E secondo lei, quali riflessioni può innescare uno spettacolo cosi’ ad un pubblico che non conosce il caso Moro e l’Italia di quegli anni?
Riflessioni che hanno a che fare col tema della giustizia e della violenza, temi universali, che sempre sono elemento di conflitto e di contraddizione.
Cosa vuol dire per un attore recitare con il teatro di narrazione? Difficoltà, sensazioni…..
Un attore che narra conosce tutta la storia e interpreta tutti i personaggi della storia, un attore che interpreta un ruolo, interpreta un solo personaggo, ma lo fa in modo più approfondito del narratore.
Sono due procedimenti molto diversi, entrambi difficili. Qui in particolare in Corpo di stato il narratore coincide con la persona dell’attore. E’ un caso davvero speciale, che mi costringe a rivestire un ruolo che è più quello di un testimone, di qualcuno che torna da un tempo passato a ricordare e a far ricordare.E’ una sensazione emotivamente ardua ama prorio per questo appassionante.
Il teatro di denuncia che ruolo può ricoprire nell’aiutare l’Italia ad estinguere la cosiddetta epidemia di “peste sociale”?
Ogni atto di denuncia, di memoria, di contrionformazione è sempre utile in una società, ancora di più quando la società è profondamente “ammalata” come la nostra. Ma per estinguere una epidemia fatta di corruzione, malgoverno, ambiguità, criminalità diffusa il teatro può fare poco, serve una politica “buona”, servono scelte coraggiose, serve un cambiamento di mentalità. Il teatro come anche l’arte può servire a far scattare campanelli d’allarme, necessari, ma non sufficienti.
Oggi, cito Beppe Grillo, si possono avere più informazioni durante uno spettacolo teatrale che leggendo un quotidiano. Sono gli artisti ad essere diventati giornalisti o i giornalisti ad essere diventati artisti?
Bisogna fare attenzione a non far diventare il teatro solo un luogo di informazioni o di proclami o di prese di posizione. La funzione del teatro non è quella di spiegare , ma di inquietare, di porre lo spettatore nella condizione di farsi domande, domande che lo riguardano come persona, come cittadino. Il linguaggio del teatro non può essere quello del giornalismo, ciò non toglie che può cogliere , nel presente, proprio per la sua grande elasticità di linguaggio, quelle cose, quei conflitti, quelle contraddizioni che il potere non vuole vedere o tende a occultare: Il teatro deve cogliere, artisticamente, il disagio che abita la società.
Durante il dibattito alla Casa Italiana della NYU è emerso il desiderio dei
giovani italiani di non essere politicizzati. Tuttavia esistono anche movimenti come i no-global. Secondo te possono essere considerati gli eredi ( o ciò che resta) del movimento degli anni ’60-’70? E quali sono le differenze e i punti di contatto (se mai ci sono) tra i due movimenti?
Non credo ci siano eredità o punti di contatto tra quei giovani di allora e i giovani di oggi. Ciò che gli anni ‘70 hanno lasciato, è divenuto parte del processo storico, le conquiste e le sconfitte sono state elaborate, metabolizzate e agiscono dentro ognuno di noi (si pensi solo alla grande apertura verso i diritti, conquistati e ormai assimilati dalla società).
Nei giovani oggi c’è maggiore informazione della globalità dei problemi, cosa che non esisteva negli anni ‘70 dove la lettura dello scenario internazionale era spesso venata di ideologia più che di informazione. Oggi manca però un orizzonte di passioni, un’utopia da condividere. Non basta, credo, essere contro la globalizzazione. Servono poi orizzonti di speranza, di cambiamento, cose concrete per cui valga la pena lottare . Ma sono fiducioso, visto dove sta precipitando questo mondo occidentale, credo che l’emergenza ambientale potrebbe divenire un grande cavallo di battaglia per milioni di giovani.
Source URL: http://newsite.iitaly.org/magazine/article/intervista-marco-baliani
Links
[1] http://newsite.iitaly.org/files/9251balianifoto1242245934jpg